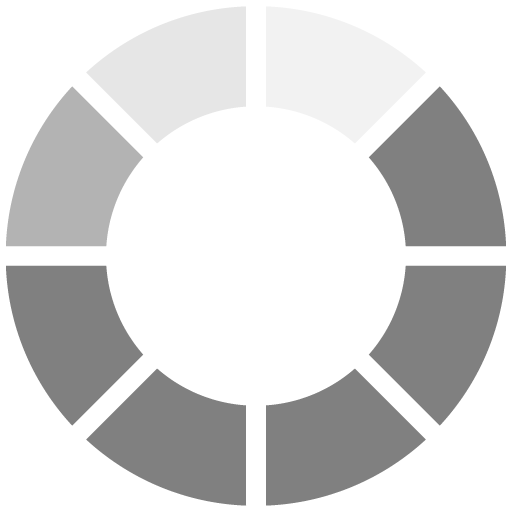LA VITA INTERA E’ UN ESERCIZIO DI PERDITA
Il lutto non è solo la fine della vita, ma di fasi, relazioni, esperienze, parti dell’esistenza. Un libro di Schreiber riflette sul distacco, sull’etica della memoria e sulla possibilità di accogliere il vuoto.
C’è una soglia silenziosa che prima o poi attraversiamo tutti. A volte ci arriviamo all’improvviso, a volte ci camminiamo accanto per anni.
È la soglia del lutto – una parola antica e insieme presente, futura, che spesso si nasconde dietro ai tabù della conversazione.
Quando si parla di morte, si tende a parlare a bassa voce. E quando si parla di dolore, spesso si tende a non parlarne affatto, a nascondere, farne un fatto privato. Eppure, oggi più che mai, il lutto chiede il suo spazio. Lo chiedono i libri, i saggi, i progetti artistici e sociali che provano a restituire dignità a qualcosa che non può essere risolto, ma solo attraversato.
C’è chi affronta il lutto contribuendo alla ricerca scientifica, chi partecipando a lotte politiche, c’è chi riflette da anni sulla morte nel digitale, come il tanatologo Davide Sisto e chi come Chandra Livia Candiani invece intreccia poesia e silenzio, lutto e compassione. Ci sono ricercatori, artisti, filosofi che studiano e raccontano il lutto da prospettive inedite: tra questi Damiano Fina, esperto di death studies, e voci internazionali come Francis Weller (The Wild Edge of Sorrow) o Nice Harrison con The Grief Space.
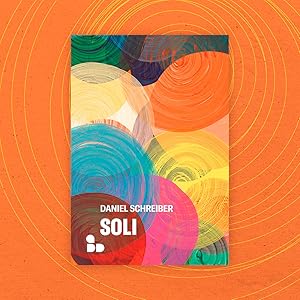 A queste voci si aggiunge quella dell’autore tedesco Daniel Schreiber, che dopo aver pubblicato nel 2023 con add editore il libro Soli – sul non fallimento personale della vita solitaria – torna in libreria con la casa editrice torinese con Il tempo della perdita (pagine 128, euro 16), per parlare di lutti, addii, distacchi, accettazione (o mancata accettazione), partendo dalla perdita del padre, ma alla luce dell’esperienza globale dello smarrimento di un intero pianeta che si sta trasformando, fino ad arrivare a una riflessione – senza ambizioni di sorta – sul senso dell’esistenza; proprio per questa ragione è un libro di interrogativi – non di risposte – sul distacco, che – in fondo – abita da tempo anche la nostra cultura popolare, senza però arrivare al dunque: vedi in letteratura L’anno del pensiero magico di Joan Didion, un testo che si può definire iconico del genere, o in altre arti La stanza del figlio di Moretti, che racconta la morte improvvisa di un giovane nella vita di una famiglia, o ancora la serie tv After Life di Ricky Gervais, dove il sarcasmo è un modo per affrontare il dolore, o ancora podcast che mettono al centro per esempio il tema dell’educazione alla perdita.
A queste voci si aggiunge quella dell’autore tedesco Daniel Schreiber, che dopo aver pubblicato nel 2023 con add editore il libro Soli – sul non fallimento personale della vita solitaria – torna in libreria con la casa editrice torinese con Il tempo della perdita (pagine 128, euro 16), per parlare di lutti, addii, distacchi, accettazione (o mancata accettazione), partendo dalla perdita del padre, ma alla luce dell’esperienza globale dello smarrimento di un intero pianeta che si sta trasformando, fino ad arrivare a una riflessione – senza ambizioni di sorta – sul senso dell’esistenza; proprio per questa ragione è un libro di interrogativi – non di risposte – sul distacco, che – in fondo – abita da tempo anche la nostra cultura popolare, senza però arrivare al dunque: vedi in letteratura L’anno del pensiero magico di Joan Didion, un testo che si può definire iconico del genere, o in altre arti La stanza del figlio di Moretti, che racconta la morte improvvisa di un giovane nella vita di una famiglia, o ancora la serie tv After Life di Ricky Gervais, dove il sarcasmo è un modo per affrontare il dolore, o ancora podcast che mettono al centro per esempio il tema dell’educazione alla perdita.
Parlare di lutto oggi significa anche interrogare la cultura in cui viviamo: comprendere quali dolori riconosciamo e quali respingiamo, e Schreiber questo lo fa con la delicatezza e la profondità necessarie. Il suo è un testo poetico, con sfumature psicologiche significative: nella primissima pagina una frase mi ha colpito: «Avverto una certa gratitudine dentro di me». Una frase apparentemente scontata, come scontato spesso è l’essere grati, anche e soprattutto grati di essere vivi. La differenza a volte la fa proprio accorgersene. Anche perché – come sottolinea l’autore tedesco – il lutto non è solo la fine della vita, ma la fine di qualunque cosa. Sperimentiamo la perdita quotidianamente con gli oggetti, con le relazioni, con le esperienze.
Il lutto è parte integrante dell’intera esistenza, ogni giorno, in modi diversi.
Prenderne coscienza – suggerisce il libro – può essere un primo passo, così come stare in ascolto: «Prenderci carico dell’eredità dei nostri fantasmi – scrive Schreiber – è per Derrida una questione etica. Dobbiamo parlarne e fare in modo che non si smetta di farlo. Solo così avremo la possibilità di affrontare i lutti e le perdite».
Eugenio Giannetta – Quotidiano Avvenire
13 luglio 2025