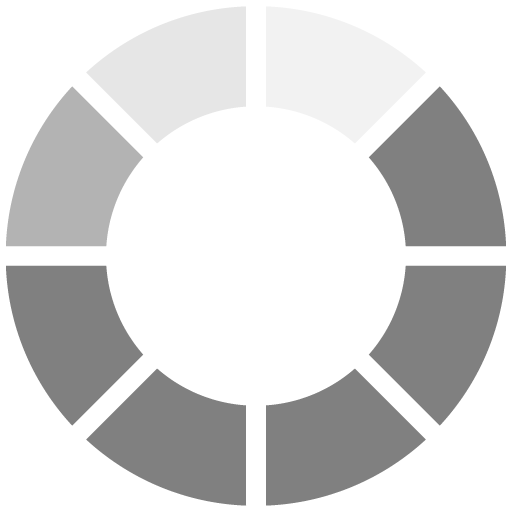Il senso di colpa nel tempo del lutto
Non potendo farsene una ragione, se ne fece un torto.
Nell’antichità, il sentimento del senso di colpa era vissuto in modo diverso da come lo intendiamo oggi, carico dell’intenzionalità profonda che accompagna le nostre azioni. Per i Greci antichi, ad esempio, questa emozione si legava soprattutto alla sfera civica dell’onore e del disonore di fronte alla propria comunità. Faceva eccezione il gesto intenzionale dell’omicidio per il quale il senso di colpa doveva essere emendato con una pena da scontare cui nessuno poteva sottrarsi, né uomo né dio.
Il senso di colpa moderno, inteso come sentimento che accompagna una sfera di azioni e pensieri molto più ampia, si affaccia successivamente nella nostra cultura, ampliandosi in tutti gli aspetti etici, sociali, psicologici che orientano la coscienza.
In ambito psicologico, il senso di colpa viene studiato come un’emozione negativa che si manifesta quale risposta a un’azione sentita sbagliata o a un’incapacità (per esempio i non fatti, i non detti, il non essere) vissuta come inaccettabile e può essere influenzato da fattori culturali, sociali e personali. Talvolta può essere un mezzo per responsabilizzare le persone e le istituzioni verso i problemi globali futuri, ma più spesso costituisce un ostacolo al cambiamento, alla riparazione e, per quello che riguarda la mia esperienza come operatrice del servizio di Rimanere Insieme di Advar, anche al lasciar andare il proprio caro defunto.
Il senso di colpa nel tempo del lutto
Il senso di colpa è infatti spesso presente nelle persone che hanno subito un lutto: “non ci sono riuscito…”, “non ero presente…”, “non ho potuto dirglielo…” etc. Sono tanti i sensi di colpa portati dai dolenti e che si esprimono nella narrazione attraverso tanti ‘se’ che finiscono col trattenere le persone come sospese in una dimensione paralizzante tra ciò che poteva essere ‘se’… e ciò che non è stato.
Nella nostra esperienza di operatori ci accorgiamo che il senso di colpa irrompe anche quando non c’è una responsabilità diretta: esso nasce dall’esigenza della mente di controllare, creando un suo mondo fatto di cause ed effetti dove potersi rifugiare e che anestetizzi l’angoscia del caos e dell’irreversibilità della morte.
Ricordo ancora un figlio che, nel corso di un colloquio avvenuto alcuni anni fa, mi raccontò come si sentisse profondamente in colpa per aver lasciato da solo il padre nell’esatto istante in cui era spirato: “Avevo trascorso ininterrottamente più di tre giorni al suo capezzale – mi disse – e non ce la facevo più a stare sveglio. Uscii a prendere un caffè alla macchinetta a qualche metro dalla sua camera e lui, proprio allora, spirò. Non riesco a perdonarmi che mio padre fosse solo in quel momento”.
Il fatto è che la nostra mente non può accettare la morte e, quindi, il limite. Viviamo in una società in cui tutto richiede una soluzione in tempi rapidi (a ogni sintomo del corpo è pronta la medicina giusta, per esempio), la morte costituisce una sconfitta – quasi una beffa! – per la ragione umana che ha raggiunto, oggi, grandiose eccellenze in tutti i campi. La mente, impegnata per tutta la vita a risolvere problemi, di fronte alla morte fa i conti col suo limite: la morte è, per la mente, ‘il problema dei problemi’ e la sua colpa è di non riuscire a risolverlo.
Penso per esempio alla storia di una donna che si rivolse a noi dopo la morte del marito e che passava in continua rassegna tutti i motivi per cui lui si era ammalato, prendendo infine la decisione di diventare vegetariana. Nel suo cambiare stile alimentare c’era di certo la consapevolezza di prendersi cura di sé, ma anche la necessità di controllare l’angoscia per la propria di morte, sedata con un’azione che riteneva utile per sé e che, nel suo specifico caso, ebbe anche il potere di sciogliere il senso di colpa di non essere riuscita a far star meglio suo marito.
Non potendo farsene una ragione, se ne fece un torto
In greco antico la parola che indica “essere colpevole di qualcosa” (amartànein) viene talvolta usata anche nel significato di “perdere”, come si legge nella tragedia dell’Alcesti di Euripide al verso “perdere la fedele consorte”. Ecco dunque come la perdita di una persona cara, fin dall’antichità, nel tentativo di contrastare l’impotenza che la morte evoca, elicita il sentimento di sentirsi colpevoli per qualcosa che non può essere cambiato ed evitato come un lutto e così “non potendo farsene una ragione, se ne fece un torto”, recita un vecchio adagio.
C’è da sottolineare, comunque, che il senso di colpa ha anche un valore adattivo e protettivo, come è emerso all’ultimo convegno nazionale dei gruppi di auto mutuo aiuto del lutto, tenutosi ad Agrigento l’11 aprile scorso, cui ha partecipato anche Rimanere Insieme Advar: “Il senso di colpa – ha spiegato uno dei relatori, lo psicoterapeuta Enrico Cazzaniga – è un sentimento che aiuta chi ha subìto un lutto ad adattarsi al caos in cui è piombato, ma a un certo punto va accettato il proprio limite, perché non si può più cambiare questo film ed è inutile e dannoso il continuo rimuginio. Non siamo onnipotenti”.
Certo, non è facile lasciar andare quel senso di colpa, perché esso cela anche il dolore immenso che ogni dolente ha dentro di sé e che costituisce talvolta il modo possibile per tenere vivo il legame col proprio caro.
Come fare allora per integrare queste parti che non trovano pace?
Ancora una volta sono gli Antichi a venirci in soccorso con il Mito di Sisifo.
 Il mito di Sisifo e i pesi che si portano
Il mito di Sisifo e i pesi che si portano
Un uomo, chiamato Sisifo, venne sottoposto dal re degli dei, Zeus, a una terribile fatica: doveva sospingere fino alla cima di una collina un pesantissimo masso, finché questo non rotolava giù a valle. Ma a Sisifo non riusciva mai di compiere quest’impresa perché, una volta giunto in cima, il macigno ritornava indietro schiacciandolo e lui doveva ricominciare tutto daccapo, per l’eternità.
I miti antichi hanno valori simbolici e allegorici, tramandano antiche sapienze sulla natura profonda dell’essere umano e sul suo agire.
Il mito di Sisifo può esserci allora utile come metafora del nostro continuo punirci per aver fatto qualcosa che riteniamo ‘sbagliato’: ci carichiamo sulle spalle il senso di colpa come un vero e proprio macigno da spingere verso l’alto, sperando di sentirci meglio ma non è così, perché ogni volta tutto ricomincia di nuovo, in un processo che rischia di non avere mai fine. Questa riflessione è ancor più vera per i dolenti che vivono sensi di colpa legati alla perdita del loro caro, che purtroppo continueranno a rinnovare se l’esperienza del lutto non sarà illuminata dalla luce della consapevolezza elaborativa, grazie a un percorso di aiuto.
Leggendo però meglio tra le righe del mito, scopriamo un indizio utile al dolente: nella terribile fatica che Sisifo deve affrontare, emergono in lui anche risorse personali importanti che lo aiutano, quali la forza, la tenacia, la costanza, la volontà. Potrebbe gettarsi a terra e arrendersi. Invece continua a salire quella collina, passo dopo passo, restando con quello che c’è e forgiando se stesso.
Queste risorse appartengono anche alle persone che hanno vissuto un lutto e, se riconosciute durante il processo elaborativo, possono davvero trasformarsi in energia utile e feconda, che nutre e sostiene. Quando accade questo, il senso di colpa viene lasciato andare e riconosciuto come un sentimento che mette in luce altre parti di noi utili all’elaborazione, grazie alla quale il dolore della perdita viene mitigato e la vita può acquistare un nuovo senso prima impensabile.
Paola Fantin, équipe di ADVAR Rimanere Insieme